Siamo veramente sicuri che si possa arrivare al “bene” attraverso il “male”? Infliggere il “male” in nome e per conto del “bene” porta davvero ad ottenere il “bene”? Infliggendo il male non si corre il rischio di educare al male?
 <<Dall’antichità, e in parte fino ai giorni nostri, l’educazione è stata praticata attraverso il sistema di (premi e) punizioni. […] Platone, nel Teeteto fa dire a Protagora che ‘chi manca di virtù umana deve essere fornito a forza di castighi così da farlo diventare migliore’, […] Aristotele ritiene che si possano istruire i giovani solo con la sofferenza; [esiste una] storia di connubio tra punizione (o castigo) ed educazione, [come dimostra] l’uso della bacchetta a scopo educativo ancora nel secolo passato.
<<Dall’antichità, e in parte fino ai giorni nostri, l’educazione è stata praticata attraverso il sistema di (premi e) punizioni. […] Platone, nel Teeteto fa dire a Protagora che ‘chi manca di virtù umana deve essere fornito a forza di castighi così da farlo diventare migliore’, […] Aristotele ritiene che si possano istruire i giovani solo con la sofferenza; [esiste una] storia di connubio tra punizione (o castigo) ed educazione, [come dimostra] l’uso della bacchetta a scopo educativo ancora nel secolo passato.
Per imparare bisogna soffrire: questo era (ed è spesso anche oggi) il riferimento degli educatori; bisogna soffrire anche per imparare a rispettare le leggi: si ubbidisce non per forza della ragione ma perché si teme una sofferenza maggiore di quella che costerebbe facendo ciò che si vuole (disubbidire). Ma siccome nessuno (salvo casi di masochismo e fraintendimenti) vorrebbe che gli venisse imposta una sofferenza, perché si accetti che chi ha sbagliato deve essere punito è necessario rompere qualsiasi riconoscimento reciproco: posso ammettere che è giusto fare soffrire soltanto colui che considero diverso da me. Quando non si riconosce che l’altro è uguale a se stessi la morte, la tortura, i lavori forzati, la privazione della libertà sono accettate largamente dalla cultura generale, si trasformano in regola, in legge, e diventano il modo di rispondere della comunità alla violazione della legge.
La pena può essere ritenuta giusta in assoluto, senza che sia necessario dare una spiegazione del perché che vada al di là della giustezza del punire. […] Oppure può essere ritenuta giusta in quanto strumento per raggiungere scopi predeterminati. Non si punisce perché si è commesso un reato ma perché non si commettano reati in futuro.
[…]
Nel comune modo di pensare, la resistenza nei confronti di un sistema non retributivo della sanzione continua a essere particolarmente elevata: la risposta al reato più frequente dell’opinione pubblica consiste nella richiesta di maggior severità delle pene. Si sente spesso invocare “tolleranza zero”, e soltanto in pochi si pongono il problema del recupero alla società di chi ha infranto le leggi.
[…]
 L’idea retribuzionista della pena è fondata sull’idea che sia giusta l’esclusione. Si può retribuire il male con il male solamente se si ritiene che l’espulsione dalla relazione con l’altro sia umanamente (e metafisicamente e teologicamente) non solo ammissibile, ma anche positiva al verificarsi di certe condizioni. Come si è accennato, si tratta dell’esplicazione di una cultura più ampia, che ha le proprie applicazioni anche in altri campi, primo tra tutti quello educativo. Il modello funziona, al di là delle parole, pressappoco così: poiché hai rotto la relazione affettiva con me (con la comunità, con Dio), meriti che io (la comunità, Dio) rompa la relazione affettiva con te. E quanto più grave è stata la rottura, tanto più grave deve essere la frattura da parte mia (della comunità, di Dio). Se la rottura della relazione è consistita, per esempio, nell’eliminazione della fisicità altrui, anche la tua fisicità deve essere eliminata (e quindi la pena deve essere la morte, sia essa effettiva oppure figurata, come nella prigione a vita). Se la rottura non è esaustiva, devi subire un allontanamento, un’esclusione proporzionata all’esclusione del rapporto effettivo che avevi causato tu. Se la retribuzione è considerata un imperativo categorico che si giustifica in sé, come ritiene Kant (ma anche Lutero), ci si ferma qui. In caso contrario, si attribuiscono alla retribuzione capacità educative: avendo provato l’esclusione (e avendo sentito che l’esclusione fa soffrire) ti asterrai in futuro dal tagliare la relazione con me (la comunità) perché avrai imparato dalla tua sofferenza […]. Non solo: l’idea che la frattura della relazione possa portare all’esclusione educa anche gli altri membri della comunità a evitare di compierla, per il timore che l’esclusione inflitta a chi ha a sua volta escluso possa essere applicata anche a loro.
L’idea retribuzionista della pena è fondata sull’idea che sia giusta l’esclusione. Si può retribuire il male con il male solamente se si ritiene che l’espulsione dalla relazione con l’altro sia umanamente (e metafisicamente e teologicamente) non solo ammissibile, ma anche positiva al verificarsi di certe condizioni. Come si è accennato, si tratta dell’esplicazione di una cultura più ampia, che ha le proprie applicazioni anche in altri campi, primo tra tutti quello educativo. Il modello funziona, al di là delle parole, pressappoco così: poiché hai rotto la relazione affettiva con me (con la comunità, con Dio), meriti che io (la comunità, Dio) rompa la relazione affettiva con te. E quanto più grave è stata la rottura, tanto più grave deve essere la frattura da parte mia (della comunità, di Dio). Se la rottura della relazione è consistita, per esempio, nell’eliminazione della fisicità altrui, anche la tua fisicità deve essere eliminata (e quindi la pena deve essere la morte, sia essa effettiva oppure figurata, come nella prigione a vita). Se la rottura non è esaustiva, devi subire un allontanamento, un’esclusione proporzionata all’esclusione del rapporto effettivo che avevi causato tu. Se la retribuzione è considerata un imperativo categorico che si giustifica in sé, come ritiene Kant (ma anche Lutero), ci si ferma qui. In caso contrario, si attribuiscono alla retribuzione capacità educative: avendo provato l’esclusione (e avendo sentito che l’esclusione fa soffrire) ti asterrai in futuro dal tagliare la relazione con me (la comunità) perché avrai imparato dalla tua sofferenza […]. Non solo: l’idea che la frattura della relazione possa portare all’esclusione educa anche gli altri membri della comunità a evitare di compierla, per il timore che l’esclusione inflitta a chi ha a sua volta escluso possa essere applicata anche a loro.
[…] Il profilo educativo, [del] fare male (pur nell’esercizio della funzione autoritativa della risposta alla trasgressione) non può che insegnare, irrimediabilmente, a fare male: non si può insegnare a non uccidere uccidendo; non si può insegnare a non privare gli altri della libertà togliendola. La sofferenza imposta non può, non è in grado di convincere, e semmai insegna a obbedire. Ma chi obbedisce non è psicologicamente, se non giuridicamente, responsabile delle proprie azioni (ne è responsabile chi da l’ordine). La pena, quindi, anziché creare responsabilità la distrugge.
[…]
L’atteggiamento culturale secondo il quale la pena deve consistere in retribuzione ed esclusione porta con sé la convinzione profonda, forse non del tutto consapevole, che chi esce dal carcere non può essere riammesso alla società. La retribuzione non si ferma nel momento in cui la pena è stata scontata del tutto, ma prosegue anche dopo. Chi ha commesso il male va estromesso dai rapporti con gli altri permanentemente. Succede così che la persona scarcerata trovi molto difficilmente un lavoro, un’abitazione, più in generale opportunità di reinserirsi nella società.
[…]
E’ d’altra parte puramente illusorio che il carcere (la pena, la sofferenza imposta) abbiano il potere di riparare la vittima, o meglio il conflitto instauratosi tra lei e chi ha leso i suoi diritti, la sua dignità, la sua persona. Cosa riceve, la vittima, dalla sofferenza del colpevole? Solo ed esclusivamente la soddisfazione dell’istinto di vendetta. Di un istinto negativo, che andrebbe controllato invece che enfatizzato: si consideri che paradossalmente proprio l’affidamento del potere di punire alla collettività – allo Stato anziché alla vittima – è stato un passo verso il ridimensionamento della vendetta privata, della quale è stata colta la negatività per il vivere sociale. Ci si è fermati però a metà strada, e la vendetta, benché oggettivata, ha continuato a essere il criterio informatore della risposta alla sanzione. La vittima, però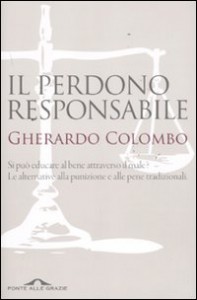 , dal fatto che il suo aggressore debba subire una pena non riceve nulla, al di fuori della vendetta. Non è riparata, non è aiutata a superare il trauma subito dall’aggressione alla sua dignità, non è assistita nel recuperare, per quanto possibile, l’integrità perduta. Al di là delle apparenze, la sua partecipazione si risolve soltanto nell’assistere, a volte con grande enfasi e crudeltà (si pensi alla sua presenza all’esecuzione fisica del condannato prevista in alcuni Stati) all’elargizione del male per compensare il male, destinataria anch’essa di una sottile discriminazione piuttosto che del recupero a relazioni sociali armoniche e serene. “I paradigmi vendicativi – scrive Claudia Mazzuccato – soffocano questi bisogni reali di giustizia delle vittime e della società civile, liquidandoli ancora una volta nel magico tutto-fare delle pene…il diritto penale non ha saputo finora scrutare l’abisso di solitudine in cui può venire a trovarsi chi patisce un reato e ascoltarne il grido urgente; ha fatto risuonare forte, nella società, l’istinto irrazionale della vendetta invece di sopirlo e anzi lo ha cavalcato”.
, dal fatto che il suo aggressore debba subire una pena non riceve nulla, al di fuori della vendetta. Non è riparata, non è aiutata a superare il trauma subito dall’aggressione alla sua dignità, non è assistita nel recuperare, per quanto possibile, l’integrità perduta. Al di là delle apparenze, la sua partecipazione si risolve soltanto nell’assistere, a volte con grande enfasi e crudeltà (si pensi alla sua presenza all’esecuzione fisica del condannato prevista in alcuni Stati) all’elargizione del male per compensare il male, destinataria anch’essa di una sottile discriminazione piuttosto che del recupero a relazioni sociali armoniche e serene. “I paradigmi vendicativi – scrive Claudia Mazzuccato – soffocano questi bisogni reali di giustizia delle vittime e della società civile, liquidandoli ancora una volta nel magico tutto-fare delle pene…il diritto penale non ha saputo finora scrutare l’abisso di solitudine in cui può venire a trovarsi chi patisce un reato e ascoltarne il grido urgente; ha fatto risuonare forte, nella società, l’istinto irrazionale della vendetta invece di sopirlo e anzi lo ha cavalcato”.
Gherardo Colombo, “Il perdono responsabile. Si può educare al bene attraverso il male? Le alternative alla punizione e alle pene tradizionali”, Ponte alle Grazie, Milano 2011, pp. 22-24, 35-36, 47-48, 51-52, 71, 75-76.
Gli altri LIB(e)RO PENSIERO: http://www.lindifferenziato.com/category/cultura/libri/libero-pensiero-libri/
 L'indifferenziato – San Giovanni Incarico Giornale di Cultura e Informazione San Giovanni Incarico
L'indifferenziato – San Giovanni Incarico Giornale di Cultura e Informazione San Giovanni Incarico





…”Il modo in cui puniamo i criminali dice molto riguardo al modo in cui concepiamo noi stessi”. […] Ferguson, professore alla Columbia di una disciplina crossover intitolata Law, Literature, and Criticism ha il vantaggio di essere un ibrido accademico. La sua analisi dialoga con i teorici classici della punizione, con il codice penale, con i dati intorno alla riabilitazione dei prigionieri e agli effetti di lungo periodo di certe pratiche punitive, ma anche con Kafka, Dostoevskij, Dante, Hugo, Aristotele e Bentham, mettendo in piedi un’indagine con dichiarate ambizioni antropologiche: “La punizione, dopo tutto, è dettata tanto dal carattere di chi punisce quanto da quello di chi è punito”. E’ impossibile, per Ferguson, afferrare fino in fondo le strutture e i meccanismi racchiusi nel sistema carcerario senza porsi una domanda fondamentale: “Chi siamo? La domanda è particolarmente pertinente in un momento in cui definizioni innovative di ‘sé’ e della ‘gente’ hanno preso a dominare il dibattito psicologico e politico in un paese che cambia. […]
“Perché il cittadino americano medio mostra pochissima preoccupazione riguardo a un sistema carcerario che nella pratica è più duro di quello di qualunque altro stato, esclusi i regimi totalitari?”, si chiede Ferguson. Occorre un viaggio negli abissi reconditi della coscienza personale e di un intero popolo per abbozzare una risposta. […]
In fondo alla coscienza americana per la punizione è radicata un’idea di giustizia “vendicativa”, scrive Ferguson, ordinata allo scopo di diminuire lo status umano dei prigionieri, di disumanizzarli, di passare dal “hai sbagliato, dunque meriti di essere punito” a “sei intrinsecamente malvagio”. Non c’è un nesso logico cogente in questo passaggio, nota l’autore, ma esiste una deriva psicologica che trasforma l’oggetto della punizione in un criminale irredimibile. […]
La condizione di criminale rimane impressa a vita come una lettera scarlatta. Strano: in una società che rifugge in qualunque ambito della vita privata e pubblica le decisioni irreversibili – sul matrimonio, i figli, l’educazione, il lavoro, l’identità sessuale: tutto deve essere sempre rivedibile, liquido, mai definitivo – i carcerati spiccano come un’eccezione alla regola. “I prigionieri in questo paese sono stati messi da parte, azzittiti, picchiati, tormentati in modo sadico, e soprattutto dimenticati spesso per tutta la loro vita. Sono stati relegati a condizioni, circostanze e a un degrado fisico che li ha umiliati e che dovrebbe umiliare anche noi; e nessuno vuole ammettere questo fatto, anche se l’incapacità di ammetterlo è a sua volta un tratto che ci definisce”…
Mattia Ferraresi
http://www.ilfoglio.it/articoli/v/91631/rubriche/demoni-dietro-le-sbarre.htm